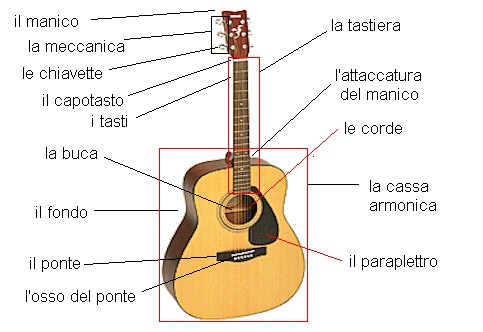
Un glossario dei termini principali
In questa lezione cominceremo a definire i termini che ci accompagneranno nel
corso delle successive lezioni.
Impareremo a conoscere lo strumento e le sue parti, vedremo i tipi principali di
chitarre e le differenze funzionali.
Vediamo subito le parti principali che compongono lo strumento.
Per le definizioni faremo riferimento allo strumento nella configurazione tipica
denominata "acustica folk"; vedremo in seguito cosa distingue questa
configurazione dalle altre.
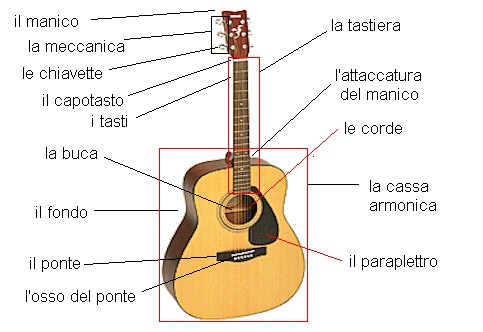
Attraverso le chiavette è possibile agire sulla trazione delle corde per
procedere alla accordatura, che è il procedimento (che spiegheremo in
seguito) attraverso il quale si fa in modo che ogni corda emetta un determinato
suono previsto per il particolare schema di accordatura.
Esistono diversi schemi di accordatura che dipendono, molto spesso, dal genere
musicale. Il più noto, e quello cui noi faremo riferimento, è l'accordatura
della classica. Vedremo in seguito lo schema e le modalità per procedere ad
essa.
Resta fermo che l'accordatura è una procedura indispensabile, effettuata
una-tantum, prima di iniziare a suonare lo strumento.
Il suono di una corda dipende da due distinti fattori
- la trazione della corda
- la lunghezza della corda
Del primo fattore abbiamo già fatto cenno, passiamo al secondo.
La chitarra è dotata di appositi tasti. I tasti sono delimitati
attraverso apposite bacchettine di metallo, distribuite lungo il manico della
chitarra.
Facendo pressione con le dita della mano sinistra nello spazio tra due bacchette
metalliche, detto appunto tasto, si determina un accorciamento virtuale della
corda, in corrispondenza della bacchetta che delimita il tasto
"pigiato" rivolta verso la buca.
Grazie a questo accorciamento è possibile variare il suono di una corda
rispetto a quello prodotto dalla accordatura base della corda stessa.
In corrispondenza della parte superiore del manico, c'è un indispensabile pezzo,
detto capotasto, che determina la lunghezza base della corda e quindi il
suono che essa emetterà suonandola vuota,senza cioè pigiare tasto. Tale
suono, una volta effettuata l'accordatura, é fisso.
Da quanto detto è chiaro che è indispensabile, per ottenere un suono pulito, pigiare
il tasto al centro delle due bacchette metalliche che li
delimitano e non sopra le bacchette stesse.
Salvo che non si sia mancini, i tasti vanno premuti utilizzando la mano
sinistra e le corde vanno pizzicate, in corrispondenza della buca, utilizzando
la mano destra.
La funzione della cassa armonica è quella di amplificare il suono che
gli viene trasferito attraverso le vibrazioni prodotte dalla corda e che
transitano attraverso il ponte.
Il pratica, il suono prodotto dalle corde è quello dato dalla
"frequenza" di vibrazione delle corde stesse. Intendiamo con tale
termine, il numero di vibrazioni che una corda fa al secondo.
Un oggetto in vibrazione, come la corda, trasferisce tali vibrazioni all'aria
circostante, producendo un alternarsi di compressioni e dilatazioni dell'aria
stessa.
Tali compressioni e dilatazioni si propagano nello spazio circostante arrivando
fino al nostro orecchio.
Nel nostro orecchio la membrana, "eccitata" dalle
"oscillazioni" prodotte dalla "onda sonora", entra in
vibrazione con la medesima frequenza.
In questo modo riusciamo a percepire il suono.
E' quindi chiaro che l'elemento fondamentale che fa sì che la chitarra abbia
un suono (timbro) particolare é la cassa armonica.
Una cassa armonica, in genere, opera in questo modo: la base della cassa, in
materiale diverso rispetto alla parte superiore, ha la funzione di
"riflettere" il suono; la parte superiore della cassa, in cui é
praticata la buca, ha invece la funzione di "vibrare"
all'unisono con le vibrazioni prodotte dalla chitarra.
In considerazione che tali vibrazioni gli vengono trasferite attraverso il ponte,
è necessario che questo sia intimamente connesso alla parte superiore della
cassa.
Il ponte, quindi, oltre ad essere rigidamente connesso, deve essere di per se
stesso composto di materiale rigido, ma anche in grado di trasmettere le
vibrazioni senza modificarne la frequenza.
Se facessimo affidamento solo sulle vibrazioni prodotte dalla corda, data la
superficie limitata che le corde occupano nello spazio, avremmo un suono
"debole" e quindi difficilmente udibile; ecco perché è necessario
che l'oggetto che vibra occupi una superficie ampia. Ma per poter vibrare è
necessario anche che sia sottile; questo è il motivo per cui alla parte
superiore della cassa si richiedono insieme la capacità di vibrare e quindi la
caratteristica d'essere sottile ed ampia, ma anche la solidità indispensabile
per far sì che non si spacchi sotto l'effetto della trazione delle corde e
quindi dell'effetto di "tiro" che gli viene dal ponte.
La parte superiore della cassa, però, non basta.
E' necessaria la parte inferiore di essa che, oltre a fungere da supporto, deve
anche amplificare le onde prodotte da essa attraverso un effetto di
sovrapposizione delle onde e quindi di aumento della loro "potenza"
sonora.
Tale effetto è ottenuto con le riflessioni delle onde che avvengono all'interno
della cassa e che dipendono strettamente dalla sua conformazione caratteristica.
Il suono amplificato esce in corrispondenza della buca.
Da quanto detto di evince che per una chitarra acustica, intendendo con tale
termine le chitarre che suonano per effetto dei principi ora esposti, sono
essenziali i materiali di costruzione della cassa armonica.
Il materiale principe è ovviamente il legno, che, grazie alle sue doti di
robustezza, ma anche di flessibilità, è in grado di "vibrare" in
maniera ottimale.
Il suono prodotto dalla chitarra ed il suo caratteristico timbro é fissato,
una volta per sempre, soprattutto dai tipi di legno o dai materiali diversi
utilizzati e poi dalla forma.
Vediamo perché parliamo anche di "altri materiali".
In genere, la chitarra è sottoposta anche ad una azione di
"levigatura" del legno e di verniciatura.
La levigatura serve a dare al materiale compattezza ed omogeneità; la
verniciatura, invece, è una azione diretta, di solito, al semplice conferimento
di un aspetto esteticamente gradevole alla chitarra stessa.
La vernice (trasparente o non) non dovrebbe incidere sulle caratteristiche
sonore della chitarra, ma ciò è praticamente inevitabile; ecco perché una
errata verniciatura, oppure una verniciatura non omogenea, oppure una
verniciatura eccessiva, finiscono inevitabilmente per danneggiare
irreparabilmente la sonorità di una chitarra.
Ci sono, ovviamente, casi in cui lo studio dei materiali di verniciatura è tale
da assicurare non solo un aspetto gradevole, ma anche un contributo positivo sul
suono della chitarra; ma ciò è certamente vero solo per le chitarre di
prestigio e non certo per quelle "commerciali".
Un'altro aspetto essenziale per una buona chitarra acustica è la modalità
di attaccatura del ponte.
Abbiamo detto che il ponte deve essere solidale con la cassa, quasi fosse parte
della cassa stessa.
Per fare ciò si possono usare due tecniche: il fissaggio avvitato e
quello incollato.
Il fissaggio avvitato, concentrando l'azione di vincolo su soli due punti, fa
sì che la forza, non uniformemente distribuita, modifichi inevitabilmente
l'azione di trasferimento delle vibrazioni, provocando una attenuazione ed una
alterazione delle onde stesse. Tale alterazione, pur essendo difficilmente
percettibile, è inaccettabile su una chitarra di qualità. Ecco perché
consigliamo l'acquisto di una chitarra con ponte incollato.
Il manico deve essere di legno. Inoltre, considerata la sua particolare
funzione di fungere da supporto per i tasti e da ancoraggio per le corde
sottoposte a trazione, deve essere principalmente di legno rigido. E'
assolutamente indispensabile che esso sia assolutamente dritto. Una tecnica per
verificane velocemente tale caratteristica, è quella di imbracciare la chitarra
come un fucile, guardando dritto dalla base della cassa armonica verso la parte
superiore del manico ed utilizzando il capotasto come un mirino. In questo modo
è possibile accertare facilmente eventuali distorsioni nel manico.
Spesso i manici recano all'interno un'anima in acciaio collegata a delle viti di
trazione che, a detta dei costruttori, dovrebbero servire ad aggiustare
eventuali incurvature che il manico dovesse subire nel tempo: riteniamo tale
marchingegno di scarsa utilità, soprattutto se il manico è già alterato in
partenza.
Per quanto attiene ai tasti, non è essenziale che il materiale delle bacchette
di metallo sia particolare, ma è indispensabile che i tasti siano disposti in
maniera assolutamente corretta. Un metodo semplice per verificare ciò é il
seguente.
Sfiorando una corda alla volta all'altezza della bacchetta tra il dodicesimo ed
il tredicesimo tasto si sente un suono (non é necessario che la chitarra sia
accordata): quel suono deve essere identico a quello che si ottiene pigiando il
dodicesimo tasto di tale corda.
Una ulteriore prova da fare, ma a chitarra accordata, è quella che
potremmo definire di "frittura". Questa prova consiste nel verificare
se tutte le corde suonate in corrispondenza di tutti i tasti provocano
quell'ineliminabile ed inaccettabile effetto che è quello di
"friggere". In pratica è un effetto che capita con maggiore
probabilità man mano che si ci avvicina ai tasti prossimi alla buca. L'effetto
consiste in un caratteristico e fastidiosissimo "frrr!", che si
ode quando si suonano particolari corde.
Quell'effetto non è in genere locale, ma è distribuito, ed è uno di quelli
che determina la inaccessibilità dello strumento.
Bisogna comunque ricordare che le corde possono "friggere" anche se
non pressate bene; va quindi accertato di aver fatto la prova correttamente.
Un altro aspetto essenziale è quello connesso alla distanza delle corde dal
manico. Una distanza che super i 5 mm in corrispondenza del 12 tasto determina
una difficoltà enorme nel mantenere la posizione di un accordo: tale distanza
eccessiva, in genere maschera difetti nel manico della chitarra, che il
costruttore intende mascherare con quell'artificio. In pratica, se si
abbassassero le corde si otterrebbe un inevitabile "frittura" di molte
di esse, se non di tutte.
La meccanica, intesa come l'insieme delle chiavette che si trovano nella parte superiore del manico, deve avere due irrinunciabili requisiti:
Il primo requisito è ovvio, ed in generale, salvo in meccaniche
particolarmente usurate, è verificato. Del resto, con una cordiera nuova,
sarebbe impossibile verificarlo nei tempi di acquisto, dato il necessario
assestamento della corda nuova in trazione. Infatti una corda nuova tende
naturalmente a perdere l'accordatura, fino a che, con il tempo, non si assesta.
Il secondo è invece facilmente verificabile accordando la chitarra: in pratica,
la chiavetta deve consentire anche minime variazioni di accordatura senza
scatti.
Un negozio che si rispetti dovrebbe sempre avere le chitarre con corde già
montate ed accordate. In tal senso sarebbero pronte anche a questa verifica. In
caso diverso, vi conviene dubitare seriamente.
Il materiale di cui sono fatte le chiavette (plastica o madreperla) non ha alcun
interesse pratico ai fini della sonorità (ovviamente), ma seguono un criterio
puramente estetico, anche se chi sostiene i costi delle chiavette in madreperla,
in genere sostiene anche quelli necessari a migliorare la qualità della
meccanica.
Con il termine cordiera si indica l'insieme delle sei corde (o dodici corde
nel caso della cosiddetta "chitarra dodici corde").
La cordiera è la parte aggiornabile della chitarra, nel senso che, a
causa del logoramento, deve essere spesso sostituita.
Esistono essenzialmente tre tipi di cordiere per chitarra:
La cordiera ha una notevole importanza nella timbrica della chitarra e può
provocare variazioni del timbro sensibili anche all'orecchio di un profano.
E' però necessario ricordare che nessuna cordiera trasforma una chitarra
scadente in una buona chitarra: E' altrettanto vero che una buona chitarra può
essere "rovinata" sia nella timbrica, sia nella meccanica e nei punti
di legatura delle corde, da una cordiera scadente.
E' opportuno non scegliere le corde che presentano le estremità dotate di un
tondino metallico, in quanto, sebbene ne agevoli l'ancoraggio, potrebbe
danneggiare gli elementi di attaccatura presenti oltre l'osso del ponte. Quanto
detto non é valido per le chitarre elettriche, che sono dotate di ancoraggio
metallico ed in tal senso, essendo particolarmente resistenti, sono adatte a
questo tipo di cordiera (che nel caso specifico costituisce la norma e non
l'eccezione).
Anche se durante il nostro corso faremo sempre riferimento alla chitarra detta "acustica", andiamo anche a tracciare per sommi capi le caratteristiche e le funzionalità degli altri tipi di chitarra.
| Viene denominato in questo modo la chitarra tipica con cordiera in nylon.
La tastiera è limitata a 12 tasti e la forma della cassa armonica ha la
caratteristica forma ad 8. La buca è, in genere, finemente intarsiata
ed i legni utilizzati sono spesso particolarmente pregiati, come ebano e
palissandro. Il principio di funzionamento è del tutto identico a
quello della chitarra folk L'uso è tipicamente orientato alla concertistica ed alla musica classica. Si incontra spesso una variante di tale chitarra, utilizzata in particolare nel campo della folcloristica, la musica spagnola o argentina. In questo caso la chitarra ha ancora la tipica configurazione classica ma la cordiera é in metallo. |
|
La chitarra elettrica é basata su un principio di funzionamento radicalmente diverso. Essa utilizza le variazioni di campo elettromagnetico prodotto elettricamente da un gruppo di bobine assemblate in due o più apparati sistemati sulla cassa: i pick-up.
|
|
In pratica attraverso il principio di induzione elettromagnetica, l'oscillazione prodotta dalle corde metalliche, produce un campo elettromagnetico variabile e la frequenza di vibrazione di questo campo é identica alla frequenza di oscillazione della corda. Le bobine contenute nel pick-up trasformano le variazioni del campo elettromagnetico in un segnale elettrico variabile con frequenza pari a quella di oscillazione della corda. Il segnale prodotto viene passato ad un amplificatore e ritrasformato in onda acustica dalle apposite casse acustiche. In questo caso la cassa armonica non serve ed è infatti utilizzata unicamente quale supporto per i pick-up. Non essendo necessaria alla acustica può essere composta di qualsiasi materiale e forma. |
Il vantaggio della chitarra elettrica è la possibilità di "trattare il segnale prodotto" direttamente, modificandone le caratteristiche. Resta fermo il fatto che, in questo caso, la timbrica della chitarra dipende essenzialmente dalle caratteristiche del pick-up e della cordiera: non ci sono altri fattori determinanti, checché se ne dica.
| E' una variante alla chitarra acustica folk. La chitarra acustica a spalla mancante presenta, in genere più dei dodici tasti tradizionali. Può essere dotata, come l'acustica folk con spalla, di un pick-up ("chitarra elettrificata"), il cui funzionamento differisce da quello indicato per l'elettrica. In questo caso si tratta di un vero e proprio microfono che viene collegato all'interno della cassa della chitarra, oppure ha la membrana solidale alla cassa armonica (che in questo caso esplica la sua funzione sia che la si usi senza elettrificazione che con elettrificazione). La spalla mancante è utilizzata come mezzo per agevolare l'uso dei tasti più vicini alla buca, che sono, nel caso della chitarra con spalla come la classica, difficilmente accessibili. |
|